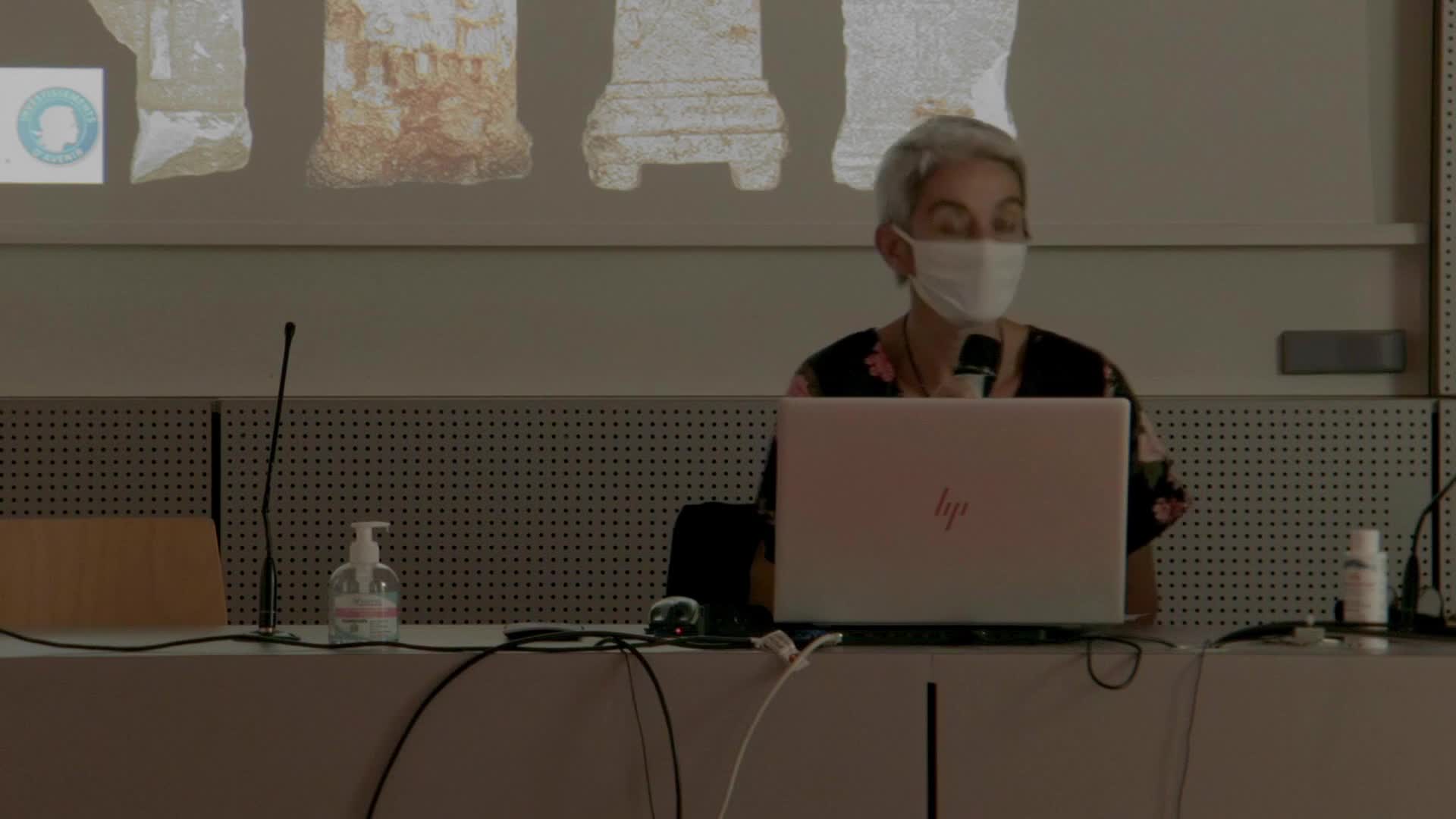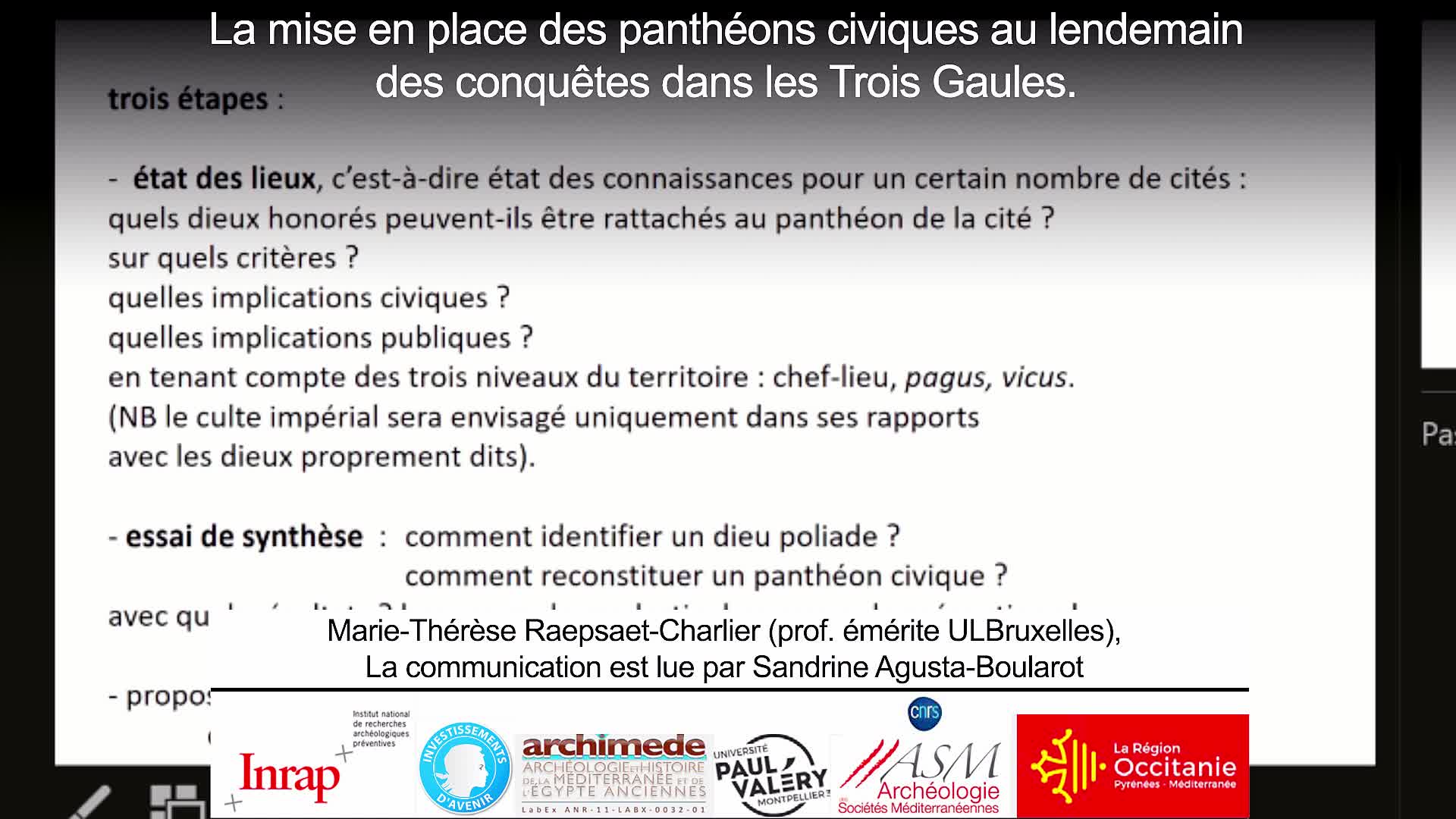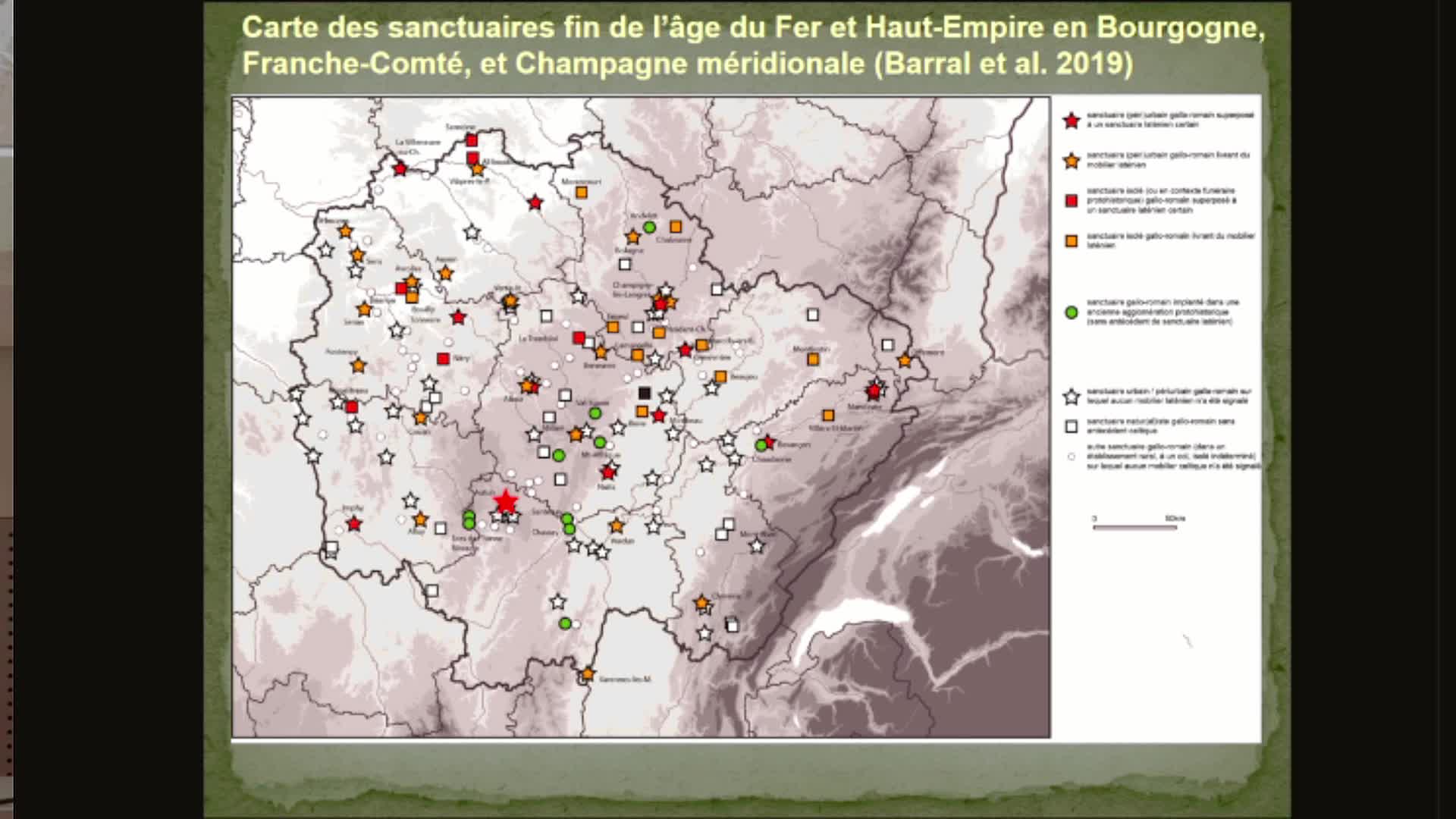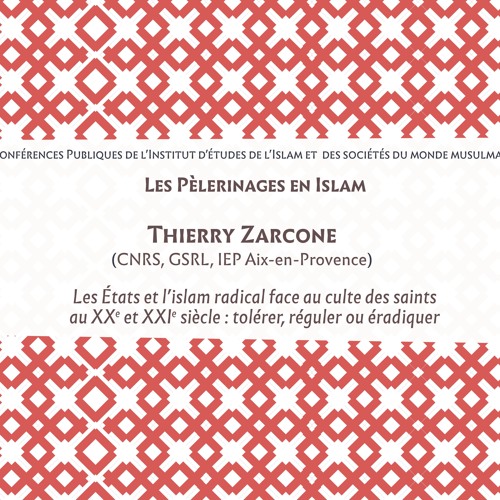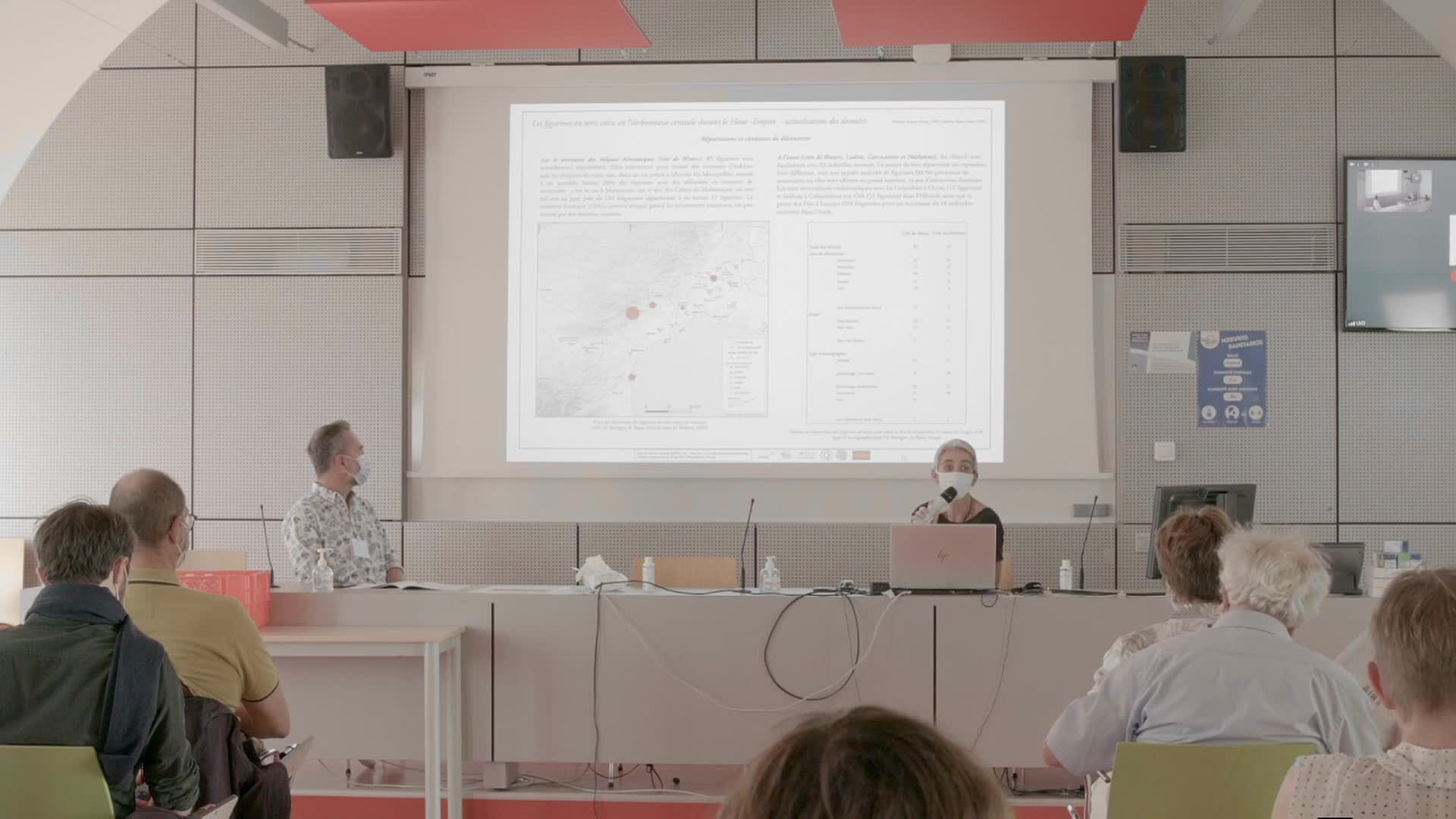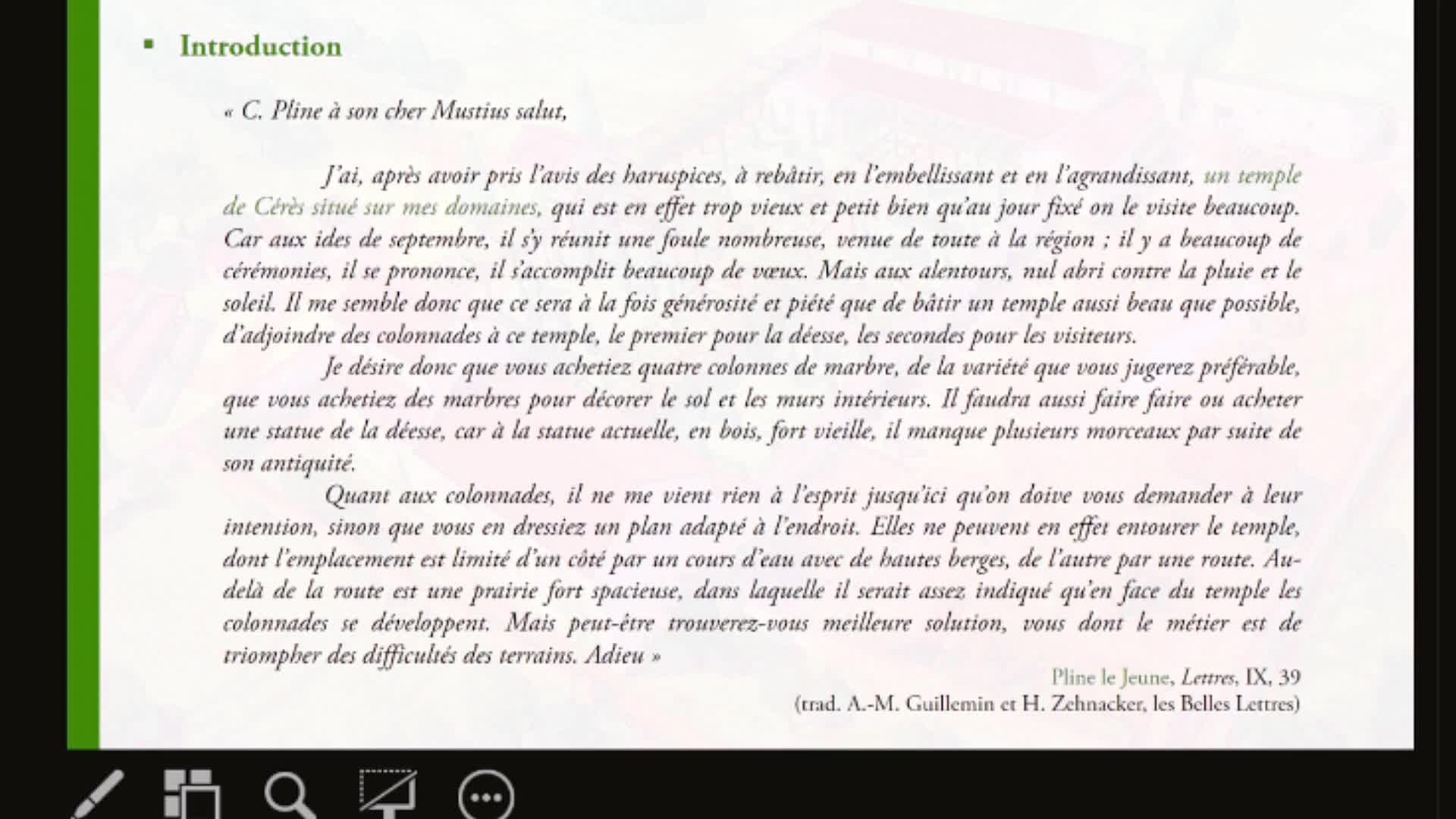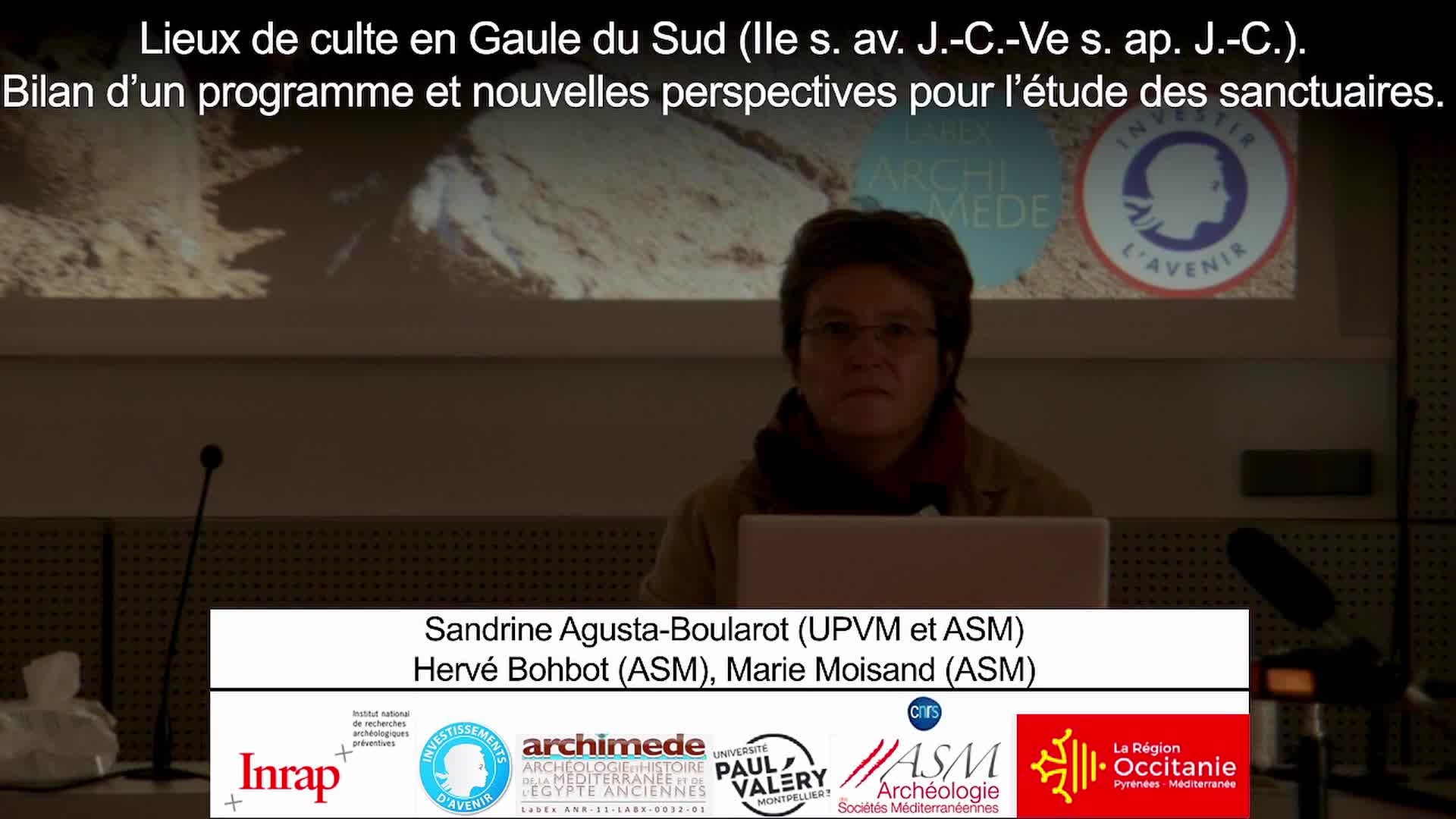Notice
Modelli indigeni e tipologie centro-italiche nell’edilizia sacra dei territori transpadani e di alcune regioni limitrofe tra II sec. a.C. ed età giulio-claudia
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
La documentazione assegnabile al II sec. a.C. e riferibile a edilizia templare di matrice centro- italica si ha nelle colonie più antiche a nord del Po, Aquileia e Cremona, ma risulta sostanzialmente limitata alla coroplastica di frontoni e coperture; per Aquileia sono anche da ricordare le fondazioni di un presunto edificio templare nel fondo Gallet e l’aedes menzionata nell’elogio di Tito Annio Lusco. La città pare diffondere il linguaggio architettonico centro- italico non solo nel suo agro, ma anche altrove, ad Altino, Este e forse Adria. Per Cremona non si hanno evidenze di un analogo fenomeno, anche se le terrecotte templari rinvenute testimoniano una qualità esecutiva rilevante.
Riguardo agli incunaboli della decorazione architettonica lapidea, i capitelli corinzio-italici di Mediolanum, dall’area centrale dell’oppidum insubre, segnalano verosimilmente l’esistenza di una struttura del tipo periptero sine postico informata delle mode della penisola.
Nulla di simile si riscontra presso i Cenomani, nel cui caput gentis le indagini hanno messo in luce un santuario di II sec. a.C., monumentalizzato secondo criteri dettati dal gusto e dalla tradizione locale.
Pur essendo pochi i contesti scavati e studiati in modo sistematico, le evidenze dai santuari extraurbani presso abitati o nel territorio mostrano spesso un lungo perdurare del culto, in alcuni casi oltre la prima età imperiale. In generale, per quanto riguarda l’area carnica, retica, veneta e cenomane, la loro veste architettonica pare pressoché inesistente, ma in molti casi è notevole l’articolazione spaziale in cui si riflettevano il percorso devozionale e l’organizzazione funzionale. Quando presenti, gli apprestamenti si limitavano a terrazzamenti, aree pavimentate, percorsi e pozzi-cisterne.
Un caso singolare è quello del sacello costruito alla fine del II sec. a.C. sul monte Castelon a Marano di Valpolicella, decorato secondo le più aggiornate tendenze urbane e - riteniamo alla luce di nuove riflessioni - concepito già in questa fase come un tempio a galleria.
Con il I sec. a. C. e i provvedimenti legislativi del 90/89 in tutta la regione si riscontra l’avvio di iniziative a carattere religioso nell’ambito delle nuove strutturazioni urbanistiche.
Ma la documentazione è assai scarsa, limitata a due attestazioni veronesi, una delle quali incerta quanto a datazione e forse più antica, a una da Oderzo, il complesso tempio-triportico dove è accertato lo schema periptero sine postico, al sacello di Tampia ad Aquileia, oltre all’episodio più significativo, anche per l’eccezionale conservazione, rappresentato dal santuario che a Brescia sostituì il precedente complesso sacro ai piedi del Cidneo. È ignoto se l’impianto a quattro tempietti allineati su una grande terrazza ricalcasse lo schema precedente o riprendesse soluzioni importate (cfr. quattro tempietti di Ostia). Alla fabbrica e alle sue decorazioni dovettero porre mano maestranze di grande abilità provenienti da area laziale-campana, oltre che nord- italica.
L’età augustea e quella giulio-claudia segnano dovunque un momento di intensa attività edilizia, concentrata soprattutto nelle aree forensi: molto particolare risulta la soluzione di Verona, dove il nuovo impianto urbano previde un Capitolium a tre celle, esastilo, di ordine tuscanico, frutto di un’operazione eccezionale nella sua rarità: la ripresa intenzionale del modello del Capitolium di Roma. La maggior parte delle città si dota di un singolo tempio (Alba, Augusta Bagiennorum, Libarna, Susa, Zuglio), alcune di due (Aosta) o di tre aedes accostate (Pola, Nesazio e forse Parenzo). Più episodica appare la costruzione di edifici cultuali in altre aree urbane ed extraurbane. Meno attestata è la ristrutturazione di precedenti impianti, completa o parziale (santuario di Marano; Brescia, complesso dei quattro tempietti). La tipologia delle piante è varia e, quando non subentrano ragioni di altra natura, risulta dettata dal contesto urbanistico. L’applicazione del periptero sine postico è abbastanza saltuaria, limitata per ora ad Alba e verosimilmente a Industria, mentre la formula prostila pseudoperiptera è ritenuta plausibile per i templi di Susa e di Augusta Bagiennorum ed è certa nel sacello di Giove Lustrale a Verona. Nelle strutture templari di piccole e medie dimensioni sembra essere preferita la tipologia prostila tetrastila, adeguata a una visione frontale e al contenimento dei costi di cantiere.
La diffusione degli edifici di culto di stampo centro-italico per quanto riguarda il periodo tardorepubblicano e la prima età augustea pare dunque riflettere le varie tappe della romanizzazione, procedendo da est a ovest, prima dell’omologazione di età giulio-claudia.
Communicants
- Giuliana Cavalieri Manasse (già Soprintendenza Archeologica del Veneto)
- Furio Sacchi (Università Cattolica del Sacro Cuore Milano)
Comité d'organisation
- Sandrine Agusta-Boularot (UPVM et ASM)
- Maryline Bovagne (Inrap Midi Méditerranée)
- Stéphanie Raux (Inrap Midi Méditerranée)
- Grégory Vacassy (Inrap)
- Ghislain Vincent (Inrap)
Réalisation - Lambert Capron
Thème
Dans la même collection
-
Regards sur les cultes et les rituels en dehors de la sphère domestique dans le Midi de la France …
Le but de cette communication est de présenter un rapide panorama de ce qui peut entrer dans la sphère du cultuel et du rituel en Gaule méditerranéenne, en dehors de la sphère domestique, dans les
-
Les inscriptions de l'esclave Niger au sanctuaire aux Mères d'Allan : réexamen d'un dossier excepti…
Fouillé en 1880, le sanctuaire de domaine d'Allan a livré une collection d'inscriptions à bien des égards, unique, en même temps qu'un enregistrement du contexte de découverte, remarquable pour l
-
Évolutions et transformations architecturales du temple central du lieu de culte ouest de la ville …
Située en Gaule Belgique, à proximité de la frontière occidentale avec la Lyonnaise, Briga (Eu, « Bois-l’Abbé », 76) offre un cas d’étude privilégié pour percevoir l’évolution d’un lieu de culte d’une
-
Que deviennent les monnaies offertes aux divinités en Gaule romaine ?
La communication propose une évolution des pratiques d’offrande monétaire tout au long de la période romaine en Gaule. Cette évolution chronologique ne s’observe pas forcément dans tous les lieux de
-
Différents témoignages de cultes domestiques et pratiques cultuelles à Nîmes durant le Haut-Empire.
En 2006-2007, la fouille préventive du Parking Jean Jaurès à Nîmes, conduite par l’Inrap, a mis au jour tout un quartier de la cité antique. Située au sud du sanctuaire de la Fontaine et de la Tour
-
L’aire de l’ex Hôtel Couronne : structures et rituels d’un lieu de culte à Augusta Praetoria (Aosta…
La fondation en 25 av. J.-C. de la colonie d’Augusta Praetoria, implantée au croisement des voies qui, franchissant les cols Alpis Graia et Alpis Poenina, mènent aux provinces Transalpines, s’intègre
-
La mise en place des panthéons civiques au lendemain des conquêtes dans les Trois Gaules.
La mission qui m’a été confiée s’est révélée particulièrement ardue à remplir. Les faiblesses de la documentation épigraphique, l’ampleur de la zone concernée, le caractère épars et souvent disparate
-
Les sanctuaires de la cité des Convènes (Ier s. av. J.-C. - Ve s. apr. J.-C.). Archéologie et épigr…
Située aux limites de la Narbonnaise, de l’Aquitaine et de la Tarraconaise, la cité pyrénéenne des Convènes présente dans le domaine des religions antiques une situation fort complexe. Cette
-
Sanctuaires et émergence des villes. Le temple « de Janus » et le quartier de la Genetoye à Autun :…
Le temple « de Janus » est situé à la sortie nord-ouest de la ville antique d’Autun, hors des remparts de l’antique Augustudunum. Il prend place au cœur d’un vaste ensemble identifiable à un
-
Permanences et innovations dans les pratiques rituelles du pays de Martigues (IIe s. av. J.-C. - II…
De la Côte Bleue à l’embouchure du Rhône, la région de Martigues est le siège de nombreux sites protohistoriques et antiques dont les fouilles ont révélé à la fois l’importance et la diversité. Après
-
Colloque international : Lieux de culte en Gaule du Sud et dans les provinces limitrophes (IIe s. a…
Conclusions et clôture du colloque. Comité d'organisation Sandrine Agusta-Boularot (UPVM et ASM) Maryline Bovagne (Inrap Midi Méditerranée) Stéphanie Raux (Inrap Midi
Sur le même thème
-
Les États et l’islam radical face au culte des saints au XXe et XXIe siècle : tolérer, réguler ou é…
ZarconeThierryHistorien et Anthropologue, Thierry Zarcone est Directeur de recherches au CNRS, rattaché au GSRL (Groupe Sociétés Religions Laïcité) et chargé de cours à l’Institut d’études politiques d’Aix en
-
Colloque international : Lieux de culte en Gaule du Sud et dans les provinces limitrophes (IIe s. a…
Conclusions et clôture du colloque. Comité d'organisation Sandrine Agusta-Boularot (UPVM et ASM) Maryline Bovagne (Inrap Midi Méditerranée) Stéphanie Raux (Inrap Midi
-
Le sanctuaire des Terrasses de Montfo à Magalas (Hérault).
Le site archéologique identifié en 2012 était inédit avant qu’un diagnostic motivé par un projet de lotissement n’en révèle l’existence, au pied d’une agglomération perchée, l’oppidum éponyme de
-
Posters
Posters Les figurines en terre cuite en Narbonnaise centrale durant le Haut-Empire – actualisation des données (P) Marilyne Bovagne (Inrap, ASM), Stéphanie Raux (Inrap, ASM) Le sanctuaire de
-
« Aedes Cereris in praediis » : temples et pratiques rituelles dans les villae de Gaule Lyonnaise.
Les instructions que Pline le Jeune donne à l’architecte Mustius, au sujet de la reconstruction et de l’embellissement du temple de Cérès qu’il a fait bâtir sur l’un de ses domaines ruraux (Lettres IX
-
Regards sur les cultes et les rituels en dehors de la sphère domestique dans le Midi de la France …
Le but de cette communication est de présenter un rapide panorama de ce qui peut entrer dans la sphère du cultuel et du rituel en Gaule méditerranéenne, en dehors de la sphère domestique, dans les
-
Permanences et innovations dans les pratiques rituelles du pays de Martigues (IIe s. av. J.-C. - II…
De la Côte Bleue à l’embouchure du Rhône, la région de Martigues est le siège de nombreux sites protohistoriques et antiques dont les fouilles ont révélé à la fois l’importance et la diversité. Après
-
Urbanisation, gestes et dépôts rituels aux premiers temps d’Vcetia : le site de l’ancienne gendarme…
Une fouille préventive menée de 2016 à 2017 par l’Inrap, environ 300 mètres au nord du centre- ville d’Uzès, a mis au jour sur 4000 m2 tout un pan de quartiers intra-muros de la ville antique, du Ier
-
Les sanctuaires de la cité des Convènes (Ier s. av. J.-C. - Ve s. apr. J.-C.). Archéologie et épigr…
Située aux limites de la Narbonnaise, de l’Aquitaine et de la Tarraconaise, la cité pyrénéenne des Convènes présente dans le domaine des religions antiques une situation fort complexe. Cette
-
Lieux de culte en Gaule du Sud (IIe s. av. J.-C.-Ve s. ap. J.-C.). Bilan d’un programme et nouvelle…
L’Atlas et le colloque, tous deux intitulés Lieux de culte en Gaule du Sud (IIe s. av. J.-C.-Ve s. ap. J.-C.), sont le fruit de plusieurs années de travail à la fois collectif et collaboratif. Après
-
Les sanctuaires de Chassenon et Saint-Cybardeaux : nouvelles données sur le fait religieux en Chare…
Depuis plusieurs années, les sanctuaires charentais de Chassenon et de Saint-Cybardeaux font, à l'instigation du Conseil départemental de la Charente, l'objet de nouvelles campagnes de fouille qui
-
Sanctuaires et émergence des villes. Le temple « de Janus » et le quartier de la Genetoye à Autun :…
Le temple « de Janus » est situé à la sortie nord-ouest de la ville antique d’Autun, hors des remparts de l’antique Augustudunum. Il prend place au cœur d’un vaste ensemble identifiable à un